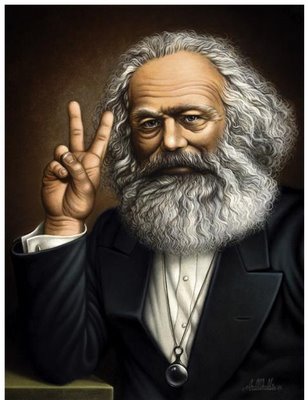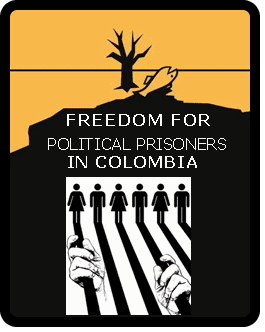Hernando Calvo Ospina: l’uomo che minacciava la Francia
Liberazione?
Berlusconi si dimette e viene da pensare alla Liberazione. E’ inevitabile. Anche se sarebbe stato decisamente più esaltante che a cacciarlo fossero state le pedate degli italiani e non il potere della finanza mondiale. Accontentiamoci per ora.
Tuttavia so che l’Italia cadra’ nelle mani di altri fascismi, forse più globalizzati, e sudore e sangue saranno versati ancora e sempre dal popolo.
E purtroppo i giovani ne pagheranno lo scotto più alto.
Non so se siamo pronti per una rivoluzione culturale che e’ quella che ci potrà salvare ma sicuramente la parte migliore di questo paese e’ quella che come sempre, sta fuori dal teatrino squallido della politica. Io la vedo tra i tanti collettivi che animano i quartieri e le università, tra le associazioni di volontariato, tra i movimenti sociali e le radio alternative, tra i militanti, singoli o associati che lottano e sognano un paese migliore, contro gli squali del potere; tra gli internazionalisti che sognano un mondo migliore, contro gli squali delle multinazionali.
La vedo nel Club dei Disadattati. Se la realta’ e’ questa, felici di esserlo. Iscrizioni aperte.
Il Club dei Disadattati
fonte foto– Argeo
CLUB DEI DISADATTATI
Dov’è la museruola? Dove sono le manette?
Dove sono l’oppressione, la prigione, l’antro del tradimento?
Si potesse con questa rosa distruggere
il suo odioso potere e il malgoverno.
Con un martello e una falce,
con il canto delle mie mani.
In questo nuovo oceano:
CLUB dei DISADATTATI?
Questa è la liberissima traduzione di una poesia che l’amico Julio Carmona, poeta e scrittore peruviano di grande talento (che ringrazio e abbraccio) ha scritto dietro la mia esplicita richiesta, quella cioè di dedicare alcuni versi al Club dei Disadattati. Lo spunto di partenza, nato casualmente su Facebook, era : “se la realtà è questa, felice di essere una disadattata”.
Perché “disadattato” o “inadeguato” che poi è quasi lo stesso viene ripetuto spesso. In famiglia sopratutto e poi in società, nel mondo del lavoro. Un disadattato è “colui che non si adatta”. A cosa? Alla società, alle regole del gioco.
Un inadeguato è “uno che non si adegua”. La stessa cosa. Se ci guardiamo intorno e vediamo quale è questa realtà alla quale viene chiesto di ageduarci o di adattarsi, allora ebbene, felici di essere dei DISADATTATI! Da lí il Club. Le iscrizioni sono aperte.
Sognatori e poeti, comunisti e scrittori di favole, trans, gay, e lesbiche, militanti, guerrilleros… fatevi avanti…
La versione originale in spagnolo e’ questa:
CLUB DE LOS DESADAPTADOS
¿Dónde, el bozal, las esposas,
La opresión o la prisión,
El antro de la traición,
Para hacer con esta rosa
La destrucción de su odiosa
Permanencia y mal estado,
Y un martillo o un arado
Con el canto de mis manos
En este nuevo oceano:
Club de los desadaptados?
(Julio Carmona)
La morte di Gheddafi e gli studenti italiani
Pubblico volentieri la lettera di Alessandro Marescotti, redattore di PeaceLink, a Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della Pace. Alessandro e’ anche docente di Lettere di un Istituto Tecnico Industriale di Taranto. Vorrei che le scuole italiane fossero piene di insegnanti come lui. Grazie Alessandro, la tua lettera mi ha commossa profondamente. Vorrei che i miei figli un giorno incontrassero maestri e docenti come te, di quelli che lasciano il segno. Io ho avuto questa fortuna, in Italia ma anche in un paesino sperduto della Colombia, dove ho capito perché in quel paese fare il maestro può anche essere un mestiere pericoloso.(AM)
Oggi i miei studenti hanno detto cose terribili
Caro Flavio,
condivido in rete queste poche parole, spero sensate. Comunque scritte con il cuore e con sincerita’.
L’epilogo vergognoso di questa vergognosa guerra richiede a mio parere una netta presa di distanza da parte della Tavola della Pace.
Quale uscita dalla crisi? La “crisi” da un altro punto di vista.
QUALE USCITA DALLA “CRISI”?
di Salvatore Ricciardi* - ottobre 2011
Partiamo dagli slogan. Se è vero che gli slogan nella loro sintesi rappresentano il sentore, la consapevolezza e il percorso politico di un movimento.
“la crisi non l’abbiamo provocata noi”… “la crisi non la paghiamo”…
Mentre la seconda affermazione ha un senso ed esprime una volontà di lotta, la prima è profondamente sbagliata.
“La crisi non l’abbiamo provocata noi”:
*ha un significato “difensivo”, “lamentoso” ed anche “giustizialista”, quasi a voler utilizzare la logica del codice penale (non l’ho commesso io, non ho colpa, non vado punito per qualcosa che non ho fatto…)
*ma soprattutto è un’affermazione non vera! Questa crisi capitalistica è si il portato di contraddizioni interne al modello di accumulazione capitalistica messo però in crisi da un’offensiva della classe operaia nei decenni Sessanta e Settanta. Quindi l’abbiamo provocata noi! E ne siamo orgogliosi!!!
Se per noi intendiamo la classe operaia, il proletariato (ma anche la “piccolissima borghesia” che possiamo definire “proletarizzata”, per intenderci: il piccolo commercio e artigianato, le piccole cooperative, le partite Iva, ecc…).
“Acuire la crisi” è un “compito storico” della classe lavoratrice, è il suo “dovere” fondamentale. La crisi capitalistica non è necessariamente un problema, può essere parte della soluzione, dal versante proletario. Può essere l’inizio della soluzione dei problemi dello sfruttamento e dell’oppressione; se però la classe lavoratrice inasprisce la crisi e non aiuta certo a risolverla; altrimenti diventa “collaborazionista” con il capitale.
La classe lavoratrice deve impedire che si “superi” la crisi, che si “esca” dalla crisi con una “ripresa economica” (che vuol dire “ripresa dei profitti del capitale”, instaurazione di un nuovo modello di sfruttamento che sottometterà e disciplinerà per un altro lungo ciclo la classe lavoratrice). La classe deve impedire che si stabilizzi il meccanismo di accumulazione imposto dal capitale in ogni sua fase di sviluppo.
Repubblica Dominicana: setta evangelica minaccia suicidio collettivo
di Annalisa Melandri - 15 ottobre 2011
A La Romana, importante centro turistico e terza città della Repubblica Dominicana, circa 200 seguaci della setta La Verdad Eterna (La Verità Eterna) hanno lasciato nella giornata di ieri le loro famiglie e le loro case, dopo aver raccolto del denaro e venduto alcune proprietà, per radunarsi in un luogo non ben identificato del paese in attesa dell’ arrivo di Cristo previsto dal fondatore della setta per il 15 ottobre, Tishri o “giorno della vittoria”. Minacciano un suicidio collettivo.
La setta La Verdad Eterna, secondo fonti interne conta con quasi 60/70mila adepti in tutto il mondo, localizzati soprattutto in Spagna ed America latina, essendo stata fondata proprio in Argentina nel 2008 da Cristian Silva, figlio di un pastore avventista. In realtà il movimento è una scissione della Chiesa Avventista del Settimo Giorno che condannano per aver accettato (dopo averlo rifiutato in un principio) il concetto della Trinità. (altro…)
Rappresentano le reti sociali la fine della piazza (reale)?
 Ne scrivevo tempo fa qui a proposito della guerra in Libia. Credo che la risposta alla domanda sia affermativa. Se non sono la fine della piazza reale sicuramente ne stanno decretando la scomparsa. Adesso anche gli scioperi diventano virtuali e vi si aderisce in Facebook.
Ne scrivevo tempo fa qui a proposito della guerra in Libia. Credo che la risposta alla domanda sia affermativa. Se non sono la fine della piazza reale sicuramente ne stanno decretando la scomparsa. Adesso anche gli scioperi diventano virtuali e vi si aderisce in Facebook.
Come questo contro la finanziaria. Comodo, molto comodo. Senza scendere in piazza, senza sporcarsi le mani, senza rischiare le botte o di perdere il posto di lavoro.
Va bene la rete, ma come luogo di scambio di informazioni, di contatti, di amicizie. (altro…)
Guerra in Libia: la rete ha ucciso la piazza?
“E’ con grande piacere che do il benvenuto al ministro Gheddafi al Dipartimento di Stato. Noi attribuiamo grande valore alle relazioni tra gli Stati Uniti e la Libia. Abbiamo grandi opportunità per approfondire e ampliare la nostra cooperazione e personalmente ho la ferma intenzione di consolidare i nostri rapporti. Pertanto, signor ministro, sia il benvenuto tra noi”. (21 aprile 2009. Mutassim Gheddafi viene ricevuto con tutti gli onori a Washington da Hillary Clinton)
Il mondo è in guerra. L’ennesima guerra neocolonialista-imperialista, questa volta per impossessarsi delle riserve di petrolio della Libia.
L’aggressione è stata realizzata tanto velocemente (il tempo per l’ennesima ridicola riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ ONU) quanto evidentemente criticabile da ogni punto di vista, soprattutto da quello dello stesso diritto internazionale con il quale pure vorrebbe legittimarsi. Non può essere infatti sostanzialmente valida una risoluzione internazionale emessa ad hoc a legittimare un intervento armato con lo scopo di imporre la democrazia, quando l’organismo che la emette diventa strumento nelle mani delle potenze mondiali. Perché infatti non si è mai intervenuto allo stesso modo contro Israele, che continua impunemente, anche in queste ore, a commettere un vero e proprio genocidio sistematico contro il popolo palestinese?
Più passano le ore e più, nel caos e nella confusione di dichiarazioni, smentite, dubbi sui ruoli e finanche sullo scopo, l’intera operazione si profila come la stessa campagna mediatica che l’ha preceduta: maldestra, confusa, improvvisata e grossolana.
Con quelle tombe in costruzione fatte passare per fosse comuni, con i bombardamenti inesistenti su Tripoli, smentiti allegramente dall’ambasciatore italiano e dal vescovo di Tripoli che proprio in questi giorni sta parlando di guerra assurda e sta invocando la “mediazione per risolvere i conflitti” (non era la stessa cosa che diceva Chávez qualche settimana fa?), bufale colossali, come i 10.000 ribelli morti e gli oltre 50.000 mila feriti, che quasi nemmeno il terremoto e lo tsunami in Giappone. Bufale che gli stessi ideatori e disinformatori di professione hanno dovuto ritirare in fretta e furia dal mercato di fronte all’evidenza dei fatti.
Campagna mediatica evidentemente grossolana proprio perché si è reso evidente il fatto che non era necessario uno sforzo disinformativo eccezionale. Si disinforma chi potrebbe, di fronte all’evidenza dei fatti, reagire in qualche modo. Chi avrebbe dovuto reagire a questa nuova guerra, e come? L’ opinione pubblica internazionale?
Perché esiste l’opinione pubblica internazionale? Di cosa o chi stiamo parlando? Di quell’ “indignazione morale condivisa per infrazioni evidenti del comandamento contro la violenza e per massicce violazioni dei diritti umani”?[1] Dove sta? Dove e come si esprime? Chávez a l’intera coalizione dell’Alba, da sud tuonano contro le mire neocolonialiste di un pugno di stati che credono che le lancette del tempo siano ancora ferme al XIX secolo, Putin, da nord parla di “crociata medievale”… In mezzo c’è l’Europa, confusa politicamente e con la voce del suo popolo, della sua gente completamente assente oggi.
Dove stanno? Dove sono le voci dei popoli? Gli unici a levare proteste contro la guerra sono alcuni presidenti, qualche governo, qualche intellettuale… Dove sono i giovani? Dove sta il sentimento pacifista che ha animato in passato le strade e le piazze europee e che è stato il fondamento, il pilastro di tutti i movimenti giovanili? Dove stanno le bandiere della pace che hanno colorato le strade e le piazze europee tra il 2002 e il 2003? Si calcola che allora in Italia quasi tre milioni furono i balconi e le finestre dove il vessillo multicolore indicava che in quella casa, in quell’ufficio, in quella scuola si stava esprimendo un forte e chiaro NO alla guerra! E le moltitudinarie proteste del febbraio 2003…
Questa è la ricostruzione che fa di quel sabato 15 febbraio 2003 lo storico statunitense J.J. Sheehan[2]: “Sabato 15 febbraio 2003 si tenne la più grande dimostrazione della storia europea, contro la guerra che stava per colpire l’Iraq. A Londra una folla di circa un milione di persone si riversò in Trafalgar Square, riempiendo le strade cittadine dagli argini del Tamigi alla Euston Station; un milione di manifestanti marciò a Barcellona e a Roma, altri 600.000 a Madrid. A sfidare il gelo al Tiergarten di Berlino furono in 500.000, un numero quasi pari ai partecipanti alla Parata dell’Amore che vi si teneva in estate. Si trattava ovunque di folle pacifiche. Ci furono pochi arresti, nessun episodio di violenza. Le dimostrazioni attirarono una ricca varietà di partecipanti: c’erano alcuni adolescenti vestiti in pelle e con l’aria da duri e giovani che indossavano la kefiah palestinese o la sciarpa nera degli anarchici, ma nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di cittadini dall’aspetto rispettabile, che indossavano caldi cappotti invernali e scarpe comode – pensionati, accademici di mezza età, membri dei sindacati, studenti delle superiori e universitari. C’erano tante famiglie, genitori e nonni che non partecipavano a una dimostrazione dagli anni Sessanta, bambini che per la prima volta facevano l’esperienza di quel caratteristico miscuglio di euforia e disagio delle manifestazioni politiche. Un quotidiano tedesco definì l’evento «una rivolta di persone comuni»…. Diversamente da chi in passato aveva manifestato contro la guerra in Vietnam, nessuno mostrava alcuna simpatia per l’altra parte; non c’erano bandiere irachene né ritratti di Saddam Hussein. Per la maggior parte di quelle persone, il vero problema non era chi aveva ragione e chi torto, ma se la guerra potesse essere considerata una risposta.”…In tutte le città coinvolte, guardando al di sopra della marea umana, la scritta che appariva più spesso era composta da una sola parola: «No».
Sicuramente, come si è visto, le proteste nulla hanno potuto contro la guerra, che a distanza di 8 anni continua cruenta ancora oggi. Tuttavia esprimevano un sentire comune, se non dei governanti, quanto meno dei governati. Esprimevano un sentimento che riuscì anche solo per un breve, anche se inutile momento, ad uscire dalle pance e a riversarsi nelle strade.
Guardando indietro con gli occhi di oggi, guardando oggi da questa Europa folle che, nel tentativo di contrastare “l’unilateralismo missionario” dell’interventismo statunitense di allora, riesce oggi ad essere soltanto una ridicola caricatura di se stessa, vediamo tuttavia che, l’ottimismo di alcuni intellettuali dovuto allora alla contemporaneità di quelle moltitudinarie proteste contro la guerra, appare oggi sicuramente esagerato. Junger Habermas e Jacques Derida nel loro appello dal titolo: Il 15 febbraio: ovvero, ciò che unisce gli europei auspicavano, credendola possibile, “la nascita di un’opinione pubblica europea” proprio a partire da quelle grandi e sentite manifestazioni di pacifismo, le “più grandi dalla fine della seconda guerra mondiale”. Oggi, rispetto ad allora, resta simile soltanto la spaccatura europea rispetto al ruolo della politica estera del continente. E all’interno dei singoli Stati le spaccature sulle posizioni da tenere, rendono tutto il gioco guerrafondaio ancora più sguaiato e meschino. Ai rumori della guerra fa eco il chiasso della politica e tutto intorno il silenzio…
Spostando la visuale, infatti, guardandoci da fuori, noi “persone comuni” del 2003, dove siamo oggi? Dove sta la nostra rabbia contro la guerra? Dove sono i nostri giovani?
Io lo so e il saperlo mi riempie di tristezza e inquietudine. I nostri giovani stanno tutti al pc. Seguendo giorno per giorno gli avvenimenti. Certo, partecipando, scrivendo (come sto facendo io stessa in questo momento), dibattendo, insultando questo o quel politico, Berlusconi come Sarkozy, Obama come Cameron, manifestando dissenso e rabbia, esponendo foto e scritte come si fa con gli striscioni in piazza.
Io non credo che sia casuale tutto questo. Io credo, sono fermamente convinta, che la rete sia una grande conquista della comunicazione, che sia una grande opportunità di crescita e di condivisione, di comunicazione e di scambio, di esperienze, di lotte, di battaglie e di informazioni. Credo però anche che sia mancato uno studio serio e intelligente degli effetti che questo mezzo avrebbe potuto avere sulla militanza, sulla protesta, sul dissenso. E questo ci ha fregati. Abbiamo pensato, nelle lunghe giornate d’inverno, o al fresco delle nostre case nelle estati assolate e torride, che fare e produrre informazione comodamente seduti davanti ad un monitor fosse in qualche modo costruttivo. Abbiamo pensato che scrivere, e scrivere, e condividere notizie, e produrre dibattito, fosse una maniera diversa e più acculturata di apportare il nostro contributo alle cause in cui credevamo e crediamo. Abbiamo pensato che far girare e condividere in migliaia di siti le orrende foto degli eccidi israeliani al fosforo bianco sui bambini palestinesi volesse dire contribuire in quale maniera a quella causa. Abbiamo pensato che mettere la bandiera della pace nelle nostre pagine web o nei nostri avatar fosse come mettercele addosso o esporle alle nostre finestre.
Sbagliavamo. Le piazze si sono svuotate, i cortei si sono fatti più silenziosi e noiosi, i colori sono lentamente sfumati. Nessuno grida più, nessuno torna a casa la sera stanco, sudato e senza voce dopo un corteo, tutti appaiono stanchi invece di tanto sbraitare e urlarsi addosso rabbia virtuale nei social forum.
Il potere ha vinto. La fantasia non è riuscita a dominarlo. In passato soffocata da tonnellate di droghe gettate addosso alle menti migliori, quelle più fervide e ribelli, poi livellata con il ventennio uniforme e squallido dell’avvento delle televisioni commerciali (che ha dato il colpo di grazia a cultura e originalità), così oggi, i centri di potere, dandoci l’illusione della libertà di espressione, facendoci credere di essere tutti partecipativi nella creazione globale dell’informazione, con quel mezzo diabolico e terribilmente geniale e seducente che è internet, hanno controllato, con meno morti e meno diffusione di malattie, ogni velleità rivoluzionaria dei giovani.
In piazza a Roma la settimana scorsa contro la guerra hanno manifestato una cinquantina di persone, il gruppo in Facebook Fuori l’Italia dalla Guerra in Libia conta 697 persone, il gruppo No alla guerra in Libia piace a 150 persone, No alla guerra contro la Libia piace a 300 persone, Io non voglio la Guerra in Libia piace a 792 persone e così via…
Paradossalmente proprio questi mezzi, internet e i suoi social Forum Facebook e Twitter, proprio quelli che hanno contribuito a creare adesione e consenso intorno a tanti militanti di alcuni paesi lontani da noi sia geograficamente che culturalmente , sono stati quelli che li hanno maggiormente isolati, chiudendoli dentro le maglie repressive della rete.
La rete, quella è la vera piazza oggi. Questa è la vera sconfitta. La nostra e del pacifismo, violento o non violento che sia, più educato e rispettoso o sguaiato e rabbioso, non importa il modo o la forma. E’ la sostanza che manca, la grande assente. Questa, signori, è la sonora e scottante sconfitta della militanza.
[1] J. Habermas, L’Occidente diviso, Editori Laterza, Roma-Bari 2005
[2]J.J. Sheehan L’età post-eroica Guerra e pace nell’Europa contemporanea (Laterza)
Flussi migratori “al femminile”: se le donne sfruttano altre donne
I flussi migratori moderni si stanno caratterizzando sempre piú per essere flussi migratori “al femminile”; si femminilizzano, come scrivono quasi tutti i piú recenti rapporti sulle migrazioni.
Questo nuovo aspetto dei fenomeni migratori è stato anche oggetto del IV Foro Sociale delle Migrazioni che si è tenuto a Quito, Ecuador, dal 8 al 12 ottobre del 2010.
Nella dichiarazione finale redatta dallˈAssemblea dei Movimenti Sociali che formavano il Foro Sociale delle Migrazioni si legge: “la femminilizzazione crescente dei flussi migratori mondiali si spiega in larga misura con lˈincorporazione delle donne nelle catene globali di assistenza familiare nei paesi di destinazione, caratterizzata da una gran precarietà lavorativa che comporta processi di degrado personali e con gravi problemi di impatto ambientale nelle comunità di origine, costituendo una delle nuove forme di schiavitù del secolo XXI. Con relazione alla tratta con fine di sfruttamento sessuale, in molti paesi si applicano le leggi di migrazione e non le leggi di protezione raccomandate dal protocollo di Palermo. [1]
Negli ultimi anni accade infatti sempre più spesso che sono le donne dei paesi più poveri del mondo che si fanno carico del ruolo di breadwinner allˈinterno delle loro famiglie, ruolo un tempo riservato alla componente maschile emigrante dei nuclei familiari. Le donne sono spesso lˈultima ancora di salvezza per milioni e milioni di famiglie schiacciate dalla povertà e impossibilitate ad uscirne. “Dei quasi 180 milioni di migranti, la metà sono donne, alcune delle quali non viaggiano più come accompagnatrici dei loro mariti ma sempre più spesso lo fanno autonomamente”[2] . Sono le donne oggi che decidono di allontanarsi dal loro paese per poter garantire ai propri cari una vita più decente e dignitosa. Lasciano la propria terra, il proprio nucleo familiare di origine, i figli e i loro mariti o compagni per emigrare allˈestero, in Europa o negli Stati Uniti, dove è sempre più richiesta una mano dˈopera al femminile per la cura delle famiglie benestanti di quei paesi.
La manodopera femminile proveniente da paesi sottosviluppati o in via di sviluppo si caratterizza per essere essenzialmente a basso costo, facilmente “addomesticabile” e ancora di più facilmente ricattabile per le peculiari caratteristiche di questo tipo di fenomeno migratorio. E a giudicare dal numero di donne sempre più elevato che trovano impiego presso le famiglie come collaboratrici familiari fisse o “ad ore”, come badanti o come baby sitter, si tratta di una manodopera per cui esiste una grande richiesta. Si calcola che il 10% circa delle famiglie italiane ricorre a una collaboratrice domestica o a una badante (la Repubblica, 2009).
La donna migrante, spesso è sola, irregolare (almeno la metà di quelle che lavorano nelle famiglie italiane) non conosce la lingua, e salvo qualche parente o amico che lˈ ha preceduta non ha nessun punto di riferimento affettivo o economico nel paese di destinazione. Ciò rende possibile una quasi dedizione assoluta da parte di queste donne alle famiglie autoctone. Soltanto in alcuni casi le reti di migranti costituiscono alternative valide alla solitudine.
La donna migrante si ritrova quindi molto spesso costretta ad integrarsi in maniera non spontanea e soprattutto non sana nella famiglia che le offre lavoro. Viene inglobata nelle case, quasi sequestrata, diventa invisibile alla società (ancor di più se non ha documenti in regola), è facilmente ricattabile, le viene chiesta dedizione assoluta anche nella sfera affettiva quando deve occuparsi per esempio dei bambini. In poche parole si annulla.
Si tratta in questi casi di relazioni lavorative fondate profondamente sul precariato, quando non su forme più o meno subdole di schiavitù vera e propria, che diventa arma di ricatto per pretendere ed ottenere sempre maggior dipendenza. Sono relazioni caratterizzate da una grave dipendenza economica ed affettiva “a senso unico”, dove il bisogno di “protezione” della migrante viene pienamente soddisfatto dalla famiglia che la accoglie e che riceve in cambio dedizione e disponibilità di tempo illimitata.
Tali relazioni lavorative hanno insite in sè processi di degradazione della persona, la quale finisce per annullarsi nel punto esatto in cui i componenti della famiglia che la ospitano ne ricavano tempo e risorse da investire nel miglioramento della qualità delle proprie vite e della gestione delle loro attività professionali. La serenità e qualità di vita decisamente elevate per le famiglie autoctone si raggiungono cosí al prezzo della disgregazione e della dispersione di migliaia di nuclei familiari del Sud del mondo. Le famiglie di origine delle donne migranti spesso si vedono private di un importante cardine di riferimento, soprattutto nelle comunità rurali e indigene. Si creano così le “famiglie trasnazionali” dove i vari membri sono dislocati in paesi diversi e il cui filo conduttore che li tiene uniti spesso è rappresentato unicamente dalle rimesse in denaro. Un terremoto relazionale di dimensioni impensabili e dalle conseguenze imprevedibili sulla stabilità del tessuto umano e sociale di interi paesi.
Ancora una volta spetta alla donna la cura del proprio nucleo familiare, anche da molto lontano. Con la femminilizzazione dei flussi migratori infatti sono proprio le donne che si devono farsi carico dei ricongiungimenti familiari, la cui realizzazione diventa sempre più difficile a causa delle nuove politiche anti-immigrazione dei governi europei.
Alcuni studi evidenziano tuttavia come alcune volte la migrazione femminile rappresenta per migliaia e migliaia di donne la possibilità di sfuggire a relazioni violente o pericolose nei loro paesi di origine e per altre costituisce effettivamente una possibilità di ottenere indipendenza e di potersi realizzare lontano da nuclei patriarcali fortemente limitativi o soffocanti,
In realtà le donne migranti rappresentano una fonte di manodopera a basso costo che ha come unica funzione quella di permettere ai nuclei familiari del primo mondo di mantenere uno stile di vita qualitativamente accettabile, nonostante i ritmi frenetici della vita nelle grandi città e la sempre maggiore quantità di tempo dedicata alle attività lavorative e imprenditoriali da parte delle donne occidentali.
Non solo. La presenza di donne immigrate nelle case delle nostre città, come badanti o baby sitter o come donne di servizio permette alle famiglie di poter sopperire a un prezzo relativamente basso alla sempre maggiore carenza nel welfare da parte dei governi europei e degli Stati Uniti.
Lˈ Italia, che ha per esempio il più alto numero di abitanti con oltre 65 anni di età è anche il paese che ha meno numero di posti letto in residenze per anziani e si colloca allˈ ultimo posto per il numero degli anziani assistiti a domicilio (appena lˈ 1%).
I servizi di assistenza familiare e di cura a bambini ed anziani, che in passato a prezzo di grandi lotte e rivendicazioni si era riusciti a rendere almeno in parte di competenza di alcune strutture pubbliche, stanno tornando a rappresentare un pesante fardello per molti nuclei familiari e questo a causa delle politiche di destra o di estrema destra di molti governi europei.
Spazi sociali in cui la partecipazione e la solidarietà riuscivano a dare un sostegno importante alle donne la cui individualità era schiacciata tra la cura dei figli, il lavoro e in alcuni casi la cura dei familiari più anziani del nucleo familiare, si perdono giorno dopo giorno in una società in cui gli spazi di condivisione con lˈaltro vengono quotidianamente annullati dallˈ idiozia teletrasmessa o dallˈ altra forma di idiozia generalizzata rappresentata dal consumismo sempre più compulsivo.
Si tratta, almeno in Europa, di intere società che stanno registrando una pericolosa regressione verso posizioni conservatrici o reazionarie per cui anche le donne europee che negli anni scorsi hanno lottato duramente per alcune conquiste in termini di liberazione e di raggiungimento di indipendenza economica ed affettiva e che oggi ne godono i frutti, si trovano ad applicare modelli di sfruttamento lavorativo e discriminatorio verso altre donne.
Eˈ tutta la società che sta registrando un pericoloso spostamento a destra della coscienza collettiva, creando nel caso specifico un sistema di cura delle famiglie improntato sulla formalizzazione, tramite queste particolari forme di rapporto di lavoro, delle classi sociali, concetto da molti revisionisti considerato fuori moda o antiquato.
Una tendenza al ribasso per lo sviluppo dellˈessere umano e che purtroppo non è caratteristico solo dei paesi occidentali o del Nord del mondo. In America latina la definizione delle classi sociali nellˈambito della cura e dellˈassistenza delle famiglie ha una struttura possiamo dire “piramidale”. Le collaboratrici domestiche che lavorano nelle case delle classi piú abbienti hanno a loro volta in casa baby sitter o bambinaie o donne ad ore proveniente da un gradino della scala sociale immediatamente inferiore a quello in cui si trovano e così via, creando vere e proprie catene di sfruttamento “al femminile”. Rari, in questo settore lavorativo, ovunque nel mondo, sono infatti i casi in cui si può parlare di rapporti di lavoro improntati sulla corretteza e sul rispetto del prossimo. Mancanza di veri e propri contratti di lavoro, salari sempre più bassi, violenze sessuali ed abusi, orario troppo lungo, maltrattamenti verbali e a volte anche fisici. Per tutta questa serie di motivi il Fondo delle Nazioni Unite per le Donne (UNIFEM) colloca lo sfruttamento delle collaboratrici domestiche tra le 16 diverse forme di violenza di genere, mentre alcuni studi arrivano a parlare di schiavitù o semi-schiavitù domestica.
Ai già noti fattori discriminatori ai quali sono sottoposti i migranti in genere e che sono quelli di razza e di classe, alla componente femminile dei flussi migratori si aggiunge anche quello di genere.
Si parla pertanto di una “doppia, tripla e a volte anche quadrupla discriminazione”, [3]una “trimurti di caratteri” impressa come un marchio a fuoco sul petto delle donne migranti.[4]
Tali forme di sfruttamento nelle nostre case, lo sfruttamento delle donne verso altre donne, quelle delle classi piú elevate su quelle povere, migranti o non, alla fine vuol significare una cosa sola: la donna non si è ancora liberata dai ruoli che la società le riserva da millenni. La cura della casa, dei bambini, dei genitori anziani se non può essere a carico della donna europea o statunitense che lo sia a carico di una filippina, di una rumena, di una peruviana ma purché rimanga strettamente a carico di una donna. La tanto sospirata parità allˈ interno della coppia la donna non lˈha sicuramente ottenuta ma è lungi dallˈ immaginarla anche allˈ interno della società.
Il fatto che la donna ricca, magari indipendente economicamente dal marito, con una vita professionale soddisfacente, abbia bisogno oggi di sfruttare altre donne per garantirsi la cura della propria casa o della propria famiglia, vuol dire soltanto che non è riuscita ad ottenere dal proprio compagno o marito la condivisione del lavoro nelle incombenze domestiche e nella cura dei figli. Rivendicazioni gridate a gran voce nei cortei femministi dei decenni scorsi, magari giustificate da manuali di moderna puericultura… la realtà dimostra purtroppo che certi compiti e ruoli sono ancora di esclusiva competenza dellˈ universo femminile.
[1] Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini. Entrato in vigore il 25 dicembre 2003
[2] CEPAL: “Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y duras realidades” — Patricia Cortés Castellanos
[3] Ambrosini M. Sociologia delle Migrazioni, il Mulino 2005
[4] Campani 2003
Ci lascia Enzo Tiezzi, scienziato e ambientalista scomodo e geniale
 E’ scomparso il 25 giugno scorso a Siena il Prof. Enzo Tiezzi, classe 1938. Accademico, ordinario di Chimica Fisica presso l’Università di Siena e scienziato ambientalista di fama mondiale, fu uno dei primi studiosi ad introdurre nel nostro paese il concetto di sviluppo sostenibile, pensato e approfondito dal grande economista ambientalista Herman Daly circa 25 anni fa. Enzo Tiezzi fu infatti l’unico italiano del gruppo dei 25 scienziati che insieme a Daly nel 1984 gettarono le basi di questo concetto e delle sue applicazioni future.
E’ scomparso il 25 giugno scorso a Siena il Prof. Enzo Tiezzi, classe 1938. Accademico, ordinario di Chimica Fisica presso l’Università di Siena e scienziato ambientalista di fama mondiale, fu uno dei primi studiosi ad introdurre nel nostro paese il concetto di sviluppo sostenibile, pensato e approfondito dal grande economista ambientalista Herman Daly circa 25 anni fa. Enzo Tiezzi fu infatti l’unico italiano del gruppo dei 25 scienziati che insieme a Daly nel 1984 gettarono le basi di questo concetto e delle sue applicazioni future.
Tre anni dopo, nel 1987, la nozione di sviluppo sostenibile venne utilizzata nel rapporto Brundtland della Commissione mondiale dell’ambiente e dello sviluppo delle Nazioni Unite. Oggi fa parte ormai del nostro retaggio culturale e della moderna pratica ambientalista ed ecologista. Da Copenhagen a Cochabamba, il nostro futuro, la nostra possibilità di sopravvivenza su questo pianeta e soprattutto quella delle generazioni che verranno, dovrà passare necessariamente attraverso l’applicazione pratica del concetto di sviluppo sostenibile.
Considerato allora concetto innovativo, lo sviluppo sostenibile (sustainable development), che come Tiezzi spiegava significa dare la possibilità di “estendere alle future generazioni lo sviluppo”, rivoluzionava completamente quello precedente di carrying capacity, cioè la capacita’ portante immediata del pianeta. Lo sviluppo sostenibile introduceva quindi implicitamente l’idea di “solidarieta’ generazionale” di cui iniziava a parlare proprio in quegli anni Herman Daly.
Grazie agli studi di Enzo Tiezzi e dei suoi collaboratori e studenti, condotti in sinergia con quelli di Trista Patterson dell’ Università del Vermount e con quelli dello stesso Daly dell’Università’ del Maryland, le amministrazioni comunali e provinciali della Toscana, dove egli ha sempre vissuto e lavorato, hanno potuto conoscere e confrontarsi, spesso applicandole in progetti innovativi, con idee nuove quali quelle di turismo sostenibile e di impronta ecologica (la differenza tra la domanda di disponibilità di risorse di un territorio e la domanda di risorse della popolazione che vi abita) e degli indicatori ecodinamici, un neologismo inventato proprio nell’ Università di Siena che indica l’insieme di “indicatori energetici, ecologici ed economici” applicati ad un sistema territoriale.
Enzo Tiezzi è stato autore di circa 20 libri e oltre 500 pubblicazioni scientifiche tradotte in varie lingue ma sicuramente “Tempi storici, tempi biologici” scritto nel 1984 e riedito con il sottotitolo “Venticinque anni dopo” da Donzelli nel 2005, e “I limiti dell’energia” del 1987 scritto con Paolo degli Espinosa sono stati i manuali scientifici di studio dell’ ambiente basilari per una generazione che iniziava ad affrontare i temi legati all’ecologia e alla salvaguardia del pianeta misurandosi con un paradigma nuovo e fino a quel momento sottovalutato, quello di tempo biologico del pianeta.
“E’ la prima volta che i tempi storici, quelli dell’organizzazione, dello sviluppo scientifico e tecnologico, della società umana e della sua espansione demografica, interferiscono con i tempi biologici, cioè con quelli della storia del pianeta, della vegetazione, della fauna, delle acque, della temperatura, dell’equilibrio biologico” scriveva Enzo Tiezzi oltre vent’anni fa.
Un monito soprattutto per la sinistra materialista, geneticamente portata ad esaurire nel tempo storico la sua visione dello scorrere del tempo. Il tempo è infinito e proprio la sua infinità ha reso possibile la formazione di cicli vitali del pianeta infinitamente lunghi se comparati con la brevità dei tempi storici. Cicli vitali tuttavia finiti, pensiamo a quelli dell’acqua e del carbonio, che possono essere irrimediabilmente compromessi se non si pone un freno allo sviluppo illimitato delle risorse, se non viene rivisto il nostro impatto sul pianeta, se non si comprende chiaramente che non “può esistere una crescita infinita su un pianeta finito” come amava ripetere Enzo Tiezzi. Se non si agisce pensando a quella “solidarietà generazionale” immaginata e studiata da Daly, lasceremo alle generazioni future un debito ecologico impossibile da saldare e da recuperare.
L’odierna crisi economica, ambientale ed ecologica, già prevista alcuni anni fa dal gruppo di ricerca dell’Università di Siena diretto da Tiezzi, va affrontata oggi secondo nuovi paradigmi. Sostituendo intanto l’indice PIL (prodotto interno lordo), “uno tra i più rozzi e stupidi che si possa immaginare dal punto di vista scientifico” con il più moderno indice di benessere economico sostenibile, ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), il nuovo indicatore economico pensato e studiato da Herman Daly che come spiegava Enzo Tiezzi nelle sue conferenze ed interviste, “prende in considerazione l’ambiente, lo stato sociale, l’energia, l’occupazione insieme ovviamente alla situazione economica”. Non un freddo insieme di calcoli ma uno studio attento della qualità della vita umana intesa come un insieme di scelte sostenibili con la vita sul pianeta.
Proprio adesso, in cui nel nostro paese da una classe dirigente arrogante e sorda ai moniti della comunità scientifica e degli ambientalisti, ma soprattutto sorda alla presa di posizione antinucleare dei cittadini italiani sancita con il referendum del 1987, viene riproposta l’opzione nucleare come scelta energetica primaria, ci viene a mancare una figura importante e un fondamentale punto di riferimento scientifico per tutti coloro che credono che la Madre Terra, come anche Enzo Tiezzi amava definirla, vada conservata e protetta perché anche le generazioni future possano avere una possibilità di vita. Nel 1987 nella scelta del NO all’ utilizzo per scopi civili dell’energia nucleare fu sicuramente fondamentale l’apporto di Enzo Tiezzi e del suo gruppo di ricerca dell’Università di Siena. Recentemente egli aveva ribadito la sua posizione in tal senso, riflettendo innanzitutto sulla pericolosità della scelta nucleare (“la sicurezza nucleare è una fiaba” aveva detto in una recente intervista) e invitando quindi a “sviluppare tutte le meravigliose, stupende energie alternative che si possono ricavare dalla Natura con effetto serra zero, a partire da quella del Sole”.
Se ne va pertanto circondato dal silenzio della stampa, serva dei grandi interessi economici e politici che sono dietro le scelte energetiche criminali che stanno decretando la fine del pianeta, un grande scienziato che ha speso tutta la sua vita per difendere il diritto delle generazioni future ad abitarlo.